Naviganti dell’ignoto
Su pareti complesse, nascoste, con accessi lunghi e faticosi, lontano dai fasti dei vicini gruppi dolomitici. Un mondo di roccia, dove le mitiche vie dei primi esploratori si uniscono a filo doppio con i difficili itinerari moderni.
Testo di Saverio D’Eredità, tratto dal numero di Meridiani Montagne "Prealpi e Dolomiti Bellunesi".
Se lo si osserva da lontano, il Col Nudo pare una vela d’argento fluttuante sull’orizzonte dolomitico. In pochi sapranno riconoscerlo, e ancora meno sono gli alpinisti che si sono messi sulla sua rotta. O forse sarebbe meglio chiamarli naviganti dell’ignoto, gente disposta a lasciare a valle le certezze per dedicarsi a un vero alpinismo di ricerca.



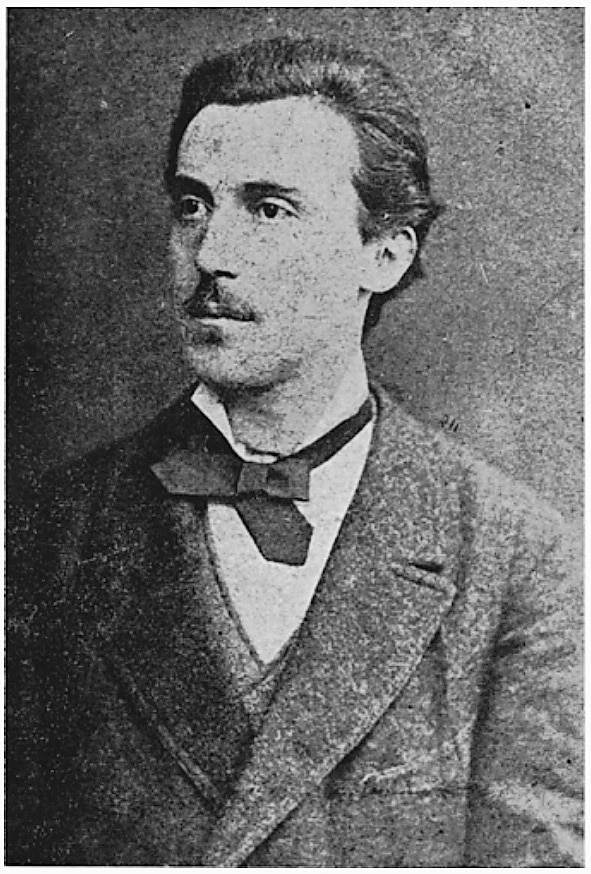
L’ultimo di questi è Luca Vallata, un “local” come si suol dire. Classe 1990, di Soverzene, piccolo paese ai piedi dell’Alpago, Luca vanta un curriculum di salite impressionante, ed è stato il primo a ripetere, insieme al bergamasco Tito Arosio, la difficile via aperta nel 1982 da Franco Miotto, Benito Saviane e Mauro Corona sulla Nord del Col Nudo (2471 m). In un’epoca interessata solo a record e primati, questa notizia non dovrebbe stupire. Ma guardando i nomi dei primi salitori e l’alone di mistero che circondava questo itinerario, l’impresa acquista un suo spessore. «Il Col Nudo è un po’ la montagna di casa» racconta Luca «e la sua parete nord è ben visibile da molte cime dolomitiche, anche se sconosciuta ai più. Frequento molto queste montagne e sapevo come attorno a questa via si fosse creata un’aura di leggenda, dovuta anche a un terrificante traverso “senza ritorno” che la caratterizza. C’erano tutti gli ingredienti per una grande avventura, ed era questo che mi attirava».
Un’avventura con la A maiuscola, perché qui scalare vuol dire andare incontro all’incertezza, alla scomodità, accettando di “sporcarsi le mani”. Luca mi parla di una via tecnicamente non così difficile (per i canoni odierni), ma su roccia «piuttosto friabile e difficile da proteggere», dove è necessaria una solida esperienza alpinistica. Cosa che di certo non mancava ai pochi coraggiosi che si sono avventurati su questi repulsivi calcari. Nello scorrere le pagine di storia alpinistica ci potremo infatti imbattere in un nome importante come quello di Dietrich Hasse, autore della celebre “diretta” sulla Nord della Grande di Lavaredo, nel 1958, e primo a salire la Nord del Col Nudo nel 1968. Ad attirare il grande alpinista sassone fu il conterraneo Wolfgang Herberg, un ingegnere tedesco che trovò sulle montagne d’Oltrepiave un vero eldorado per l’esplorazione alpinistica. Tra gli anni Cinquanta e Settanta, Herberg percorse sistematicamente queste cime dimenticate, sul solco dei pionieri come Von Glanvell, il leggendario primo salitore del Campanile di Val Montanaia (1902), nonché primo a calcare la vetta della selvaggia Cima di Pino Nord, in fondo alla remota Val Mesaz. Proprio su quelle tracce si mise Herberg, ritrovandosi a esplorare queste montagne ormai rinselvatichite con la pazienza e meticolosità dei grandi esploratori d’un tempo. Mostrò una certa predilezione proprio per le Cime di Pino, un piccolo gruppo di vette all’ombra del Col Nudo, che conservano una bellezza primigenia. In questi luoghi appartati si affacceranno poi altri alpinisti del calibro di Gogna e Corona, con vie estremamente impegnative. Un’esplorazione silenziosa, lontano dalla folla, che continua oggi con le ultime realizzazioni proprio di Vallata e compagni, i quali in anni recenti hanno aperto diversi itinerari su queste cime (l’ultima è del 2019, dedicata a Carola Rackete).
C’è però una discontinuità particolare nella storia di queste montagne. Se alpinisticamente sono state riscoperte in tempi tutto sommato recenti, in realtà le vette dell’Alpago erano conosciute già in epoche remote. La relativa facilità del versante occidentale le ha rese accessibili da sempre ai cacciatori, e successivamente ai naturalisti. Degna di nota è la salita al Cavallo – che si colloca in una fase che potremmo definire protoalpinistica – dei naturalisti Zanichelli e Stefanelli nel 1726. Mentre il primo a muoversi tra queste cime con spirito alpinistico, agli inizi del Novecento, fu l’austriaco Lothar Patera, un girovago di montagne che ha lasciato spesso la sua firma sulle Alpi Orientali. Oggi, anche grazie all’attività di alcuni scalatori locali, le pareti dell’Alpago assistono a un certo ritorno su strutture minori, ma caratterizzate da roccia fantastica, dove si pratica sia un’arrampicata plaisir (come sulle belle placche del Dolada) sia tradizionale (per esempio sulla curiosa struttura chiamata Alpagoda, in Val Salatis, scoperta da Luca Vallata).
Alpinismo titanico
Ma riprendiamo le fila e proseguiamo il nostro viaggio lungo le rotte di questi navigatori di montagne e pareti. A condurci al di là del Piave, in quelle Dolomiti che fanno da guardia a Belluno, sarà proprio Franco Miotto, la “forza della natura”, come titola la biografia scritta da Luisa Mandrino su quest’uomo dotato di un’energia fuori dal comune. Cacciatore prima, alpinista poi (iniziò ad arrampicare a 40 anni, quando i più smettono), infine esploratore dei viaz (le sottilissime cenge che, come sentieri naturali, caratterizzano le montagne bellunesi), Miotto fu protagonista di una fase intensa ed entusiasmante dell’alpinismo bellunese degli anni Settanta e Ottanta. Il suo nome è indissolubilmente legato a un’altra figura straordinaria, quella di Riccardo Bee. I due formavano una cordata estremamente prolifica, capace di individuare linee di grande bellezza e difficoltà su pareti remote.
Per capire l’alpinismo di Miotto e Bee, bisogna percorrere il vertiginoso Viaz dei camorz e dei camorzieri e affacciarsi sull’abisso del Burel, una parete nascosta che s’innalza per oltre mille metri sopra la remota Val de Piero. Un vero “abisso” (da cui l’etimologia del nome Burel) rimasto invisibile agli alpinisti fino agli anni Sessanta, più precisamente al 1967, quando in due riprese una cordata italo-polacca (di cui facevano parte i bellunesi Gianeselli e Garna) riuscì ad avere la meglio, con difficoltà estreme, su quel chilometro e mezzo verticale sbarrato da impressionanti tetti. Un’impresa storica, tentata dalle migliori cordate dell’epoca e che Messner contribuirà a portare alla ribalta, dopo la prima ripetizione con Renzler, descrivendola come una scalata “pericolosa e che richiede grande impegno morale”, da ritenere “pari alle più grandi imprese contemporanee nelle Dolomiti”. Messner si spinse a consigliare la salita a cordate di quattro elementi per aumentare la sicurezza. Miotto e Bee, invece, a digiuno di grandi imprese, erano solo in due quando ne compirono la prima invernale, nel marzo del 1974. È questo un esempio di quell’alpinismo “titanico” (come viene definito da Kulot e Bertagna nella bella biografia su Bee) di cui furono interpreti. Un alpinismo che si potrebbe definire “artigianale” (Miotto forgiava da solo i chiodi, ancora visibili su alcuni passaggi), ma soprattutto indipendente, che rifuggiva il conformismo e cercava volutamente pareti scomode, dove il tempo di un’ascensione si calcola in giorni, piuttosto che in ore o tiri di corda.
Dopo quella straordinaria invernale, aprirono altre tre vie su quella parete, tutte di elevata difficoltà, che ancora oggi ricevono pochissime visite. Bee tornò sulla Italo-polacca per la prima solitaria, poi il sodalizio con Miotto si ruppe improvvisamente. Le due strade si divisero, ma per Riccardo fu una strada breve: morirà in un tentativo solitario sull’Agner nel 1982. Miotto, invece, se n’è andato solo pochi giorni fa, il 7 ottobre, all’età di 88 anni.
A due passi da casa
Montagna dei bellunesi per eccellenza, la Schiara veglia la Valbelluna dall’alto dei suoi 2565 metri. Molto amata anche da Buzzati, che ne decantava la bellezza dei colori al mattino quando diventa la “vera, grande parete dolomitica”, venne scalata per la prima volta nel 1878 dall’agordino Cesare Tomé con la guida Santo Siorpaes e il monachese Gottfried Merzbacher. Montagna prettamente dolomitica nelle forme e nei colori, aspra e con accessi mai agevoli, è stata tradizionalmente la culla dell’alpinismo bellunese. Un posto particolare su questa bastionata rocciosa lo occupa un bizzarro monolite alto appena 40 metri, ma simbolo per tutti i bellunesi – è infatti ben visibile dalla città – ed emblema della stagione dell’alpinismo acrobatico: la Gusela del Vescovà (2361 m). Questa torre fu oggetto di tentativi quasi “circensi”, se si pensa che già nel 1909 Arturo Andreoletti pensò di salirla con una scala di legno a pioli… Tentativo fallito, poi ripreso e portato a termine vittoriosamente nel 1913, con la guida fassana Francesco Jori e Giuseppe Pasquali.
Su tutte le solari pareti della Schiara si sono avvicendate generazioni di bellunesi fin dai primi anni del Novecento. Dai fratelli Angelini a Ernani Faè, da Bepi Caldart a Roberto Sorgato, Pietro Gianneselli e Alberto Sommavilla, ciascuno con un proprio contributo significativo all’esplorazione alpinistica del massiccio. Né mancarono le visite di foresti attratti da queste Dolomiti silenziose. E parliamo di nomi importanti come Toni Hiebeler (autore della prima guida monografica del gruppo), il “greco” Georges Livanos o Richard Goedeke.
Difficilmente le pareti della Schiara saranno “di moda” tra gli scalatori, però offrono un terreno ideale a coloro che ricercano nell’alpinismo più un’esperienza globale che il solo gesto atletico. Anche a due passi da casa.
Monti invisibili
Spostandosi a ovest, sino a Feltre dove il Piave volge verso la pianura, si alzano le “Dolomiti dimenticate”. Chiuse nel silenzio di valloni impervi e disagevoli, o con accessi lunghi e faticosi e a volte con pochissimi punti di appoggio, i Monti del Sole, il Cimonega e le Vette Feltrine hanno poco da invidiare alle Dolomiti più famose, ma sembrano sparire dai radar dei primi alpinisti. A tutt’oggi i Monti del Sole, una sorta di isola selvaggia tra il canale agordino e la Valle del Mis, rimangono una delle zone più impenetrabili dell’intero arco alpino.
Sono cime dall’aspetto scontroso, spesso invisibili dal basso, e fatta eccezione per l’importante traversata del Sass de Mura dei fratelli Zsigmondy, con Purtscheller (1884), ben poco accadde negli anni delle prime esplorazioni dolomitiche. Si dovette aspettare un altro celebre navigatore di montagne come Ettore Castiglioni per assistere alla riscoperta di questi luoghi. Egli fu autore non solo di belle salite di difficoltà classiche con Bruno Detassis, ma anche della prima guida Cai-Tci che descrisse, come parte delle Pale di San Martino, le Dolomiti Feltrine.
Negli anni Trenta si affacciò da queste parti anche Emilio Comici, che osservando l’imponente parete della Palazza, nei Monti del Sole, ne ritenne fattibile una scalata “solo quando l’uomo avrà superato il settimo grado”. Tuttavia, a parte pochi alpinisti dall’animo esplorativo, come il triestino Giorgio Brunner, questi monti rimasero quasi sempre appannaggio di alpinisti locali, con il privilegio di poter trovare ampi spazi vergini ancora negli anni Sessanta. Solo alcuni itinerari ebbero una certa risonanza anche al di fuori degli ambiti locali, come la celebre diretta alla Est della Parete Piatta del Sass de Mura, tra le poche scalate divenuta (moderatamente!) classica, opera di De Bortoli e compagni nel 1973.
È una storia però solo all’apparenza minore, quella che si respira da queste parti, se si pensa che il Gruppo del Cimonega, come anche i Monti del Sole, hanno attirato grandi esponenti dell’alpinismo moderno, come i già citati Miotto e Bee, Renato Casarotto, Lorenzo Massarotto, e in tempi più recenti Gigi Dal Pozzo e Pierangelo “Pier” Verri. Scalatori che hanno portato avanti un alpinismo di ricerca, protagonisti di imprese di spessore, seppur, in realtà, poco note.
Su tutti spicca il nome di Maurizio Zanolla, in arte Manolo, che ha mosso i primi passi proprio su queste pareti. Scalava praticamente da autodidatta e prendendosi rischi enormi, lasciando la sua traccia indelebile sulla Sud della Cima di Valscura e sulla Palazza. Per poi spostare la sua attenzione sulla ricerca dell’estrema difficoltà in arrampicata libera, che lo farà diventare “il Mago”. Manolo ha forse più di altri saputo interpretare l’essenza di questi luoghi, inseguendo quelle tracce nella pietra che pochi insieme a lui sono in grado di vedere. Solo per vecchi guerrieri, l’itinerario aperto nel 2006 al Gran Burrone, nelle Vette Feltrine, non è solo la via che Manolo ha cercato per una vita, ma anche il simbolo dell’arrampicata moderna su difficoltà estreme, che unisce un eccezionale livello tecnico con un’importante dimensione mentale, in un ambiente ancora intatto. Una vera magia, che proprio qui, nelle Dolomiti dimenticate, può indicare la strada verso il futuro.
Altri approfondimenti sul numero 107 di Meridiani Montagne “Prealpi e Dolomiti Bellunesi”.




Bellissimo questo numero di Meridiani Montagne, si percepisce la natura selvaggia di questi monti, se poi si aggiungesse una decina di schede con vie di roccia “ripetibili” in zona(!), come faceva La Rivista della Montagna o Alp, sarebbe ancora meglio. Complimenti a Marco Casareto!
la foto in evidenza e’ il Sass de mura non il col nudo.